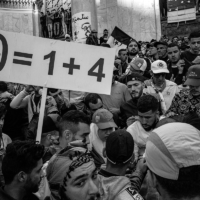People’s pouvoir
Sono i primi a scendere in strada. Scendono dalle alture della Casbah e di Ben Aknoun, arrivano dai quartieri popolari di Bab el-Oued e di El-Harrach e ogni venerdì sono alla testa degli smisurati cortei che paralizzano la capitale per abbattere il pouvoir, l’oscura e immarcescibile cricca di politici, affaristi e generali che detiene il potere. Sono gli ultras degli stadi di calcio: sfrontati, irridenti, esuberanti, con le nuche rasate, le creste colorate, le sciarpe delle squadre al collo, Instagram e Facebook alla mano. La rivolta che scuote l’Algeria è cominciata con loro.
Più del 40 per cento dei 43 milioni di algerini ha meno di 25 anni. Molti sono nati nel ventennio di Bouteflika e su di loro non fanno presa la retorica sulla guerra di liberazione dal colonialismo francese e i fantasmi del terrorismo degli anni Novanta, agitati dal governo per giustificare la censura, l’arresto dei dissidenti e dei giornalisti, l’onnipresenza della polizia e i privilegi dell’esercito. Gli stadi e i social sono gli unici spazi di aggregazione e di libertà d’espressione rimasti ai giovani.
Giovedì 14 marzo si gioca il derby cittadino tra l’Usma (Unione sportiva della medina di Algeri) e il Mca (Mouloudia club di Algeri). Le tifoserie hanno boicottato la partita per protestare contro il golpe istituzionale di “Boutef”, che violando la costituzione ha annullato le elezioni e prolungato il suo mandato. Ma sulle gradinate dello stadio “Cinque Luglio 1962” si sono radunate alcune centinaia di irriducibili. Gli slogan sono tutti politici: “Vent’anni, ora basta!”, “Niente tempi supplementari!”, “Andate tutti a casa!”, “Un solo eroe: il popolo”. Per Khalil, che spalle al campo dirige i cori della curva Usma, il regime è a fine corsa: “Abbiamo chiesto elezioni senza Bouteflika e ci hanno dato Bouteflika senza elezioni. Ma non ci faremo prendere in giro da un moribondo su una sedia a rotelle. È un insulto intollerabile al popolo algerino”.
Da anni le tribune degli stadi danno voce alla rabbia, alle rivendicazioni e alle frustrazioni di una generazione perduta, distante anni luce dall’agonizzante gerontocrazia del Fln, il Fronte di liberazione nazionale. Tra gli ultras sono nati gruppi musicali che si esprimono nell’aspro arabo dialettale dei giovani: parlano di droga, disoccupazione, emigrazione e fanno milioni di ascolti su YouTube.
Gli Ouled el-Bahdja, “i ragazzi della capitale”, tifosi dell’Usma, hanno composto un brano che è diventato l’inno della rivolta algerina. La casa d’El Mouradia, registrato in febbraio su uno smartphone e postato in rete dove ha superato sei milioni di visualizzazioni, parafrasa nel titolo la serie Netflix spagnola La casa di carta. El Mouradia è il palazzo presidenziale e il testo è un manifesto politico: “È quasi l’alba e non ho sonno, consumo droga a piccole dosi. Chi è colpevole? Chi è responsabile? Nel primo mandato ci hanno fottuto col decennio nero; alla fine del secondo l’abbiamo capito; nel terzo hanno derubato il Paese; nel quarto il pupazzo è morto ma niente è cambiato; il quinto è in arrivo, l’hanno già deciso”.
Oussama, 24 anni, studente di economia all’università Dély Ibrahim, è uno dei fondatori degli Ouled el-Bahdja. “Quando Bouteflika è diventato presidente avevo 4 anni” dice. “È assurdo. Tutto il sistema deve cambiare. Abbiamo diritto di vivere in un Paese libero e democratico”.
Numerosi altri gruppi musicali nati negli stadi sono sulla rete, come il “Torino” dei tifosi del Mca e “El Kawasser” dei sostenitori del club di El Harrach. Le loro canzoni raccontano il malessere sociale, le disuguaglianze, il carovita, gli arricchimenti illeciti, la crisi degli alloggi, le responsabilità dei politici, il dramma degli harraga, i migranti che “bruciano le frontiere” distruggendo i documenti e attraversano il Mediterraneo sui barconi: “Comprano ville a Parigi e ti lasciano marcire nella miseria e nella droga”, “Fratello perché piangi? Lasciami fuggire, anche a rischio della vita”, “Ci hanno stancato con le loro promesse e le loro storie. Il vaso è pieno, non ne posso più. La mia vita si è persa, nel vuoto e sui marciapiedi”.
Venerdì, ogni venerdì, quei canti planano sull’immensa folla che invade il centro di Algeri. Ci sono studenti, avvocati, medici, insegnanti, artisti, commercianti, anziani mujahiddin, orfani degli shuhada, i martiri dei massacri degli anni Novanta. E una marea di ragazzi e ragazze che tra le bandiere cabile e algerine sventolano gli striscioni delle squadre di calcio, occupano gli scalini della Grande Poste, lanciano slogan dai balconi di via Didouche Mourad, si arrampicano sui lampioni di piazza Maurice Audin: uno tsunami di energia vitale in sconvolgente antitesi con il mutismo, l’immobilità e il distacco degli oligarchi del pouvoir.
“Bouteflika” dice Tarik, 25 anni, disoccupato, “è riuscito nell’impresa impossibile: unire contro di lui gli algerini di tutte le tendenze politiche, di tutti i partiti e di tutti gli strati sociali”. Leila, 26 anni, agronoma: “Quelli della mia generazione se ne sono andati. Non c’è lavoro. Siamo poveri in un Paese ricco di gas e di petrolio. Ma adesso non abbiamo più paura di lottare”. Una donna con due bambini alza un cartello verso gli elicotteri militari che sorvolano la città: “Ci avete rubato il futuro. Non permetteremo che lo rubiate ai nostri figli”.
I manifestanti di Algeri non sono i gilet gialli: non un vetro rotto, non un sasso lanciato, non un cassonetto rovesciato. Prima di rincasare ripuliscono il selciato, raccolgono le lattine, i volantini e le bottiglie di plastica. E regalano fiori ai poliziotti in tenuta antisommossa che a migliaia, con centinaia di mezzi blindati, presidiano i ministeri, gli incroci, i tribunali. “Gli agenti in borghese dei servizi segreti sono dappertutto” sostiene Selim, che partecipa a un sit-in contro il suo ex sindacato, l’Ugta, da sempre asservito al regime. “Vogliono creare incidenti per scatenare la repressione. È una tecnica che conosciamo bene. Ma non cadremo nelle provocazioni. L’Algeria non è la Siria o l’Egitto: abbiamo imparato la lezione delle primavere arabe”.
Un fragoroso applauso saluta un’elegante signora con gli occhiali scuri che a 83 anni ha deciso di scendere in strada. È la mujahida Djamila Bouhired, la Giovanna d’Arco degli arabi, un’icona della guerra di liberazione: la partigiana immortalata nel film di Pontecorvo La battaglia di Algeri. Nel 1957 Djamila, allora ventunenne, era una militante del network clandestino organizzato dal comandante del Fnl Yacef Saadi nella Casbah. Arrestata dai francesi per avere fatto esplodere un ordigno in un caffè della città coloniale, fu torturata per 17 giorni e condannata alla ghigliottina, poi commutata in carcere a vita in seguito alle pressioni dell’opinione pubblica internazionale. Scarcerata nel 1962, è stata progressivamente emarginata per le sue posizioni femministe, contrarie all’adozione nel 1984 di un codice civile e famigliare di stampo islamista. “Sono fiera di voi, miei figli e nipoti” ha scritto Djamila in un messaggio ai giovani algerini. “Noi abbiamo liberato l’Algeria dal dominio coloniale; voi restituirete agli algerini la dignità e le libertà confiscate dopo l’indipendenza”.
Se l’islam politico come movimento organizzato è assente dalle piazze, non è però in declino. La nuova Grande moschea voluta da Bouteflika a Mohammadia, sull’autostrada per l’aeroporto, è quasi ultimata e sarà la terza più grande al mondo dopo quelle di Mecca e Medina, con una sala di preghiere in grado di accogliere 120 mila fedeli e un minareto alto 270 metri.
“È gia costata più di 2 miliardi di euro” sbotta il tassista che mi accompagna. “Con quei soldi i predoni che ci governano avrebbero potuto costruire 40 ospedali: quelli che abbiamo fanno schifo. Dobbiamo comprare i farmaci al mercato nero. Che bisogno c’è di un’altra moschea? Ce ne sono migliaia! Ogni casa è una moschea”. In vent’anni il numero dei luoghi di culto è raddoppiato, da dieci a ventimila. E sono in maggioranza in mano ai salafiti, che controllano anche buona parte del commercio informale, non meno del 30 per cento del pil.
Il business del trabendo, il contrabbando, non si limita ai generi di prima necessità, dal latte in polvere ai cereali, e all’elettronica di consumo. Nel maggio scorso a Orano la polizia di frontiera ha sequestrato un carico di 701 chili di cocaina nascosti in un container di carne congelata indirizzato alla ditta Dounia Meat dell’imprenditore algerino Kamel Chikhi, detto “El-Bouchi”, il macellaio. Secondo l’agenzia antidroga dell’Onu, la costa tra Casablanca e Algeri, con i suoi porti affacciati sul Mediterraneo, sta emergendo come un nuovo corridoio di transito per la coca sudamericana destinata ai mercati dell’Europa e del Medio Oriente.
L’inchiesta che ha portato all’arresto di Chikhi ha parzialmente alzato il velo sulle attività illecite di funzionari, imprenditori e magistrati corrotti, implicati nel traffico d’influenze e nel riciclaggio di denaro. Ma non si è mai avvicinata alla residenza presidenziale di Zeralda, dove al capezzale di un rais che non è più in grado nemmeno di parlare la ristretta cerchia di “consiglieri”, parenti e affaristi dedita soprattutto alla spartizione degli appalti s’illude di mantenere lo status quo. “Da molti anni Bouteflika è il passato” ironizza il direttore-fondatore del quotidiano El Watan, Omar Belhouchet. “Ma è l’unico che non l’ha capito”.
Il futuro, però, è quanto mai incerto. L’esercito, per ora, resta neutrale. Il regime cerca di guadagnare tempo per trovare una via d’uscita che accolga almeno in parte le richieste popolari senza intaccare i gruppi d’interesse costituiti. I manifestanti esigono “un cambiamento radicale del sistema”, ma al momento non hanno un progetto politico, né un portavoce. E la storia, primavere arabe incluse, insegna che raramente le rivolte di piazza hanno successo.
Nessuno, a cominciare dagli algerini, vuole che l’attuale crisi precipiti nel caos. La stabilità del più vasto Paese del continente africano è cruciale per gli Stati Uniti, che nell’Algeria hanno trovato un prezioso alleato nella lotta contro il terrorismo di matrice islamica nel Sahel. Per Mosca, che potrebbe perdere il terzo acquirente al mondo di armamenti russi. Per la Spagna, che dal deserto algerino importa la metà del suo fabbisogno di gas naturale. Per la Francia, che teme una nuova ondata migratoria. Per la Cina, che nel 2018 ha esportato beni per 8 miliardi di dollari e qui costruisce strade, raffinerie, ponti, dighe e ferrovie. E per l’Italia, primo partner commerciale di Algeri: attraverso il gasdotto sottomarino Transmed, i giacimenti sahariani di Hassi R’Mel forniscono il 28 per cento dell’import energetico della penisola.
Le incognite sono molte, i nodi difficili da sciogliere. Ma i giovani che ogni venerdì riempiono le strade di Algeri hanno una certezza: niente sarà più come prima.