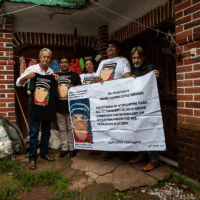PROFILE
A photobiography around the world- 1972, Boulder, Colorado
- 1977, Tamanrasset, Algeria
- 1977, Togoville, Togo
- 1980, riding in the pampas, Peru
- 1981, Islanda
- 1981, with Polisario fighters, Western Sahara
- 1984, sailing into Lebanon
- 1987, Vietnam
- 1988, Henri Mouhot’s Tomb, Laos
- 1988, with Grand Ayatollah Fadlallah in Beirut
- 1989, resting after a camel journey, Niger
- 1990, Vietnam
- 1991, Operation Desert Storm, Kuwait
- 1991, Operation Desert Storm, Saudi Arabia
- 1991, Operation Desert Storm, Dhahran, Saudi Arabia
- 1991, with Gabriella in Saudi Arabia, Operation Desert Storm
- 1992, going to Timbuctu with Tuareg fighters, Northern Mali
- 1995, Skeleton Coast, Namibia
- 1997, Nuba Mountains, Sudan
- 1997, crossing the Congo after Mobutu’s fall
- 1997, resting in the Big Man’s throne, Mobutu’s palace, Kinshasa, Zaire
- 1998, Maranello
- 1999, going into Kosovo
- 1999, Kukes, Albania
- 1999, with the Talibans, Afghanistan
- 2001, in the control tower at Baghram Air Base, Afghanistan
- 2002, somewhere in Sierra Leone
- 2002, with the Maoists in the liberated areas, Himalaya hills, Nepal
- 2002, on the Maoist trail, Nepal
- 2002, Kyrghizstan
- 2003, Iran
- 2003, at the Ministry of Information, Baghdad
- 2003, Panorama Baghdad Bureau Chief at work
- 2003, my weekly bill at the Rashid Hotel, Baghdad
- 2003, surviving in Baghdad
- 2003, the miserable life of a foreign correspondent in Baghdad
- 2003, Marco Polo goats, Pamir
- 2003, Tajikistan
- 2003, blue marlin, Habana
- 2004, in Nassiriyah, Iraq
- 2004, with rebel Commander Minni Minnawi in Darfur, Sudan
- 2004, at work in Darfur, Sudan
- 2004, with the fighters in Darfur, Sudan
- 2004, with John, Habana, Cuba
- 2004, Cuba
- 2005, with a tribal Chief in the Democratic Republic of Congo
- 2005, Lake Tahoe, California
- 2006, a desk in the jungle, Democratic Republic of Congo
- 2007, with General Pompegnani in the Green Zone, Baghdad
- 2007, my barber in Kabul, Afghanistan
- 2007, Tangeri
- 2007, bodyguard, Mogadiscio
- 2008, with Grand Ayatollah Ali Montazeri, Qom, Iran
- 2008, in the occupied West Bank, Palestine
- 2009, with a Somali refugee in Malta
- 2009, with street children in Ciudad de Guatemala
- 2009, Madrasa Binoria, Karachi, Pakistan
- 2010, Aden, Yemen
- 2010, shisha by the Nile, Malakal, South Sudan
- 2011, with Omar al-Mukhtar last son in Benghazi, Libya
- 2011, in Tahrir Square, Cairo, Egypt
- 2011, Ciudad Juarez, Mexico
- 2011, Misurata, Lybia
- 2011, Tripoli, Lybia
- 2012, Baghdad nights, Iraq
- 2012, Baghdad days, Iraq
- 2012, tribal in Ramadi, Iraq
- 2013, gang summit, Korogocho, Kenya
- 2013, Goma, RDC
- 2013, my room in Masisi, RDC
- 2013, Good Hope, South Africa
- 2013, Philippi township, Cape Town, South Africa
- 2013, Khayelitsha township, Cape Town, South Africa
- 2013, Cosovo slum, Cape Town, South Africa
- 2013, with the Imam, Jos, Nigeria
- 2013, in Jos, Nigeria
- 2013, monti Shan, Myanmar
- 2014, Niger
- 2014, Bangui
- 2014, Bangui
- 2014, Kurdistan
- 2014, Svalbards
- 2014, Syria
- 2015, North Cameroon
- 2015, Estado de Mexico
- 2015, El Salvador
- 2016, Mosul front, Iraq
- 2016, Arusha, Tanzania
- 2017, Lalibela, Etiopia
- 2017, Taiz, Yemen
- 2017, Bentiu, Sud Sudan
- 2017, Mogadiscio, Somalia
- 2018, Ile de Gorée, Senegal
- 2018, Timbuktu, Mali
- 2018, Cox’s Bazar, Bangladesh
- 2018, California
- 2018, Kabul, Afghanistan
- 2019, Jakarta, Indonesia
- 2019, Città del Messico
- 2019, Havana, Cuba
- 2019, Mexico
- 2020, Tehran
- 2021, Afghanistan, tomba di Massud
- 2022, Saudi Arabia
- 2022, Ukraine
- 2023, Hebron, Palestine
- 2023, Rwanda
- 2024, Mexico
- 2025, Chad
“Sono un reporter; Dio esiste soltanto per quelli che scrivono gli articoli di fondo” (Graham Greene).
Giovanni Porzio (Milano, 1951)
I am a travel addict and journalism, I thought, was the only job that could satisfy my nomadic spirit and my eagerness to see the world. So I started to freelance, writing and shooting pictures for several newspapers, magazines and international policy reviews.
In 1979 I joined Panorama, the leading Italian newsmagazine, where I have been working for more than thirty years as foreign editor and special correspondent, covering all major conflicts and travelling to 125 countries in Africa, the Middle East, Asia, Europe, the United States, Central and South America.
In 1991 I was among the first journalists to enter Kuwait City during operation Desert Storm and a few days later I was taken prisoner by Saddam’s Revolutionary guards during the Basra uprising.
In the following years I covered Somalia, Rwanda, Ethiopia, Eritrea, Algeria, China, Indonesia, South Africa, Palestine, Bosnia, Kosovo, Pakistan, Iran, Vietnam, Cambodia, Colombia, Haiti, Russia, Chechnya, Zaire.
In 2001 I was in Afghanistan with the mujahiddin of the Northern Alliance and entered Kabul the day the talibans left.
In 2003 I was Panorama Baghdad bureau chief during the Iraqi war and witnessed the fall of Saddam and the arrival of the American forces.
In 2006 I was in southern Lebanon during the Israeli attack on Hezbollah.
Since 2003 I’ve been regulary covering Afghanistan and Iraq, where I have been also embedded a few times with the US and Italian troops.
In 2011 I followed the Egyptian “twitter revolution” from Tahrir square, Cairo, and was in Libya during the war.
My latest assignements include: Afghanistan, Nigeria, Ethiopia, Iran, Palestine and Gaza, Georgia, Iraq, India, China, Pakistan, Sudan, Mexico, Cambodia, Myanmar, Bosnia and Syria.
As a visiting professor, I teach journalism at the Complutense University of Madrid.
I received several national and international awards, including the “2001 Max David Prize” for my work in Afghanistan, and since now I have published eight books.
As a photographer I had exhibitions in Avana (Cuba), Milano and Trieste (Italy) and at the International Journalists’ Festival in Perugia.
I fathered three kids and – with the compliments of the late Saddam Hussein - I met the woman of my life in a prison cell in Basra: they are, by far, more revealing than the pictures I shoot and more meaningful than the books and stories I’ve written in my terrestrial journey.
I AM A REPORTER. GOD EXISTS ONLY FOR LEADER-WRITERS
di Giovanni Porzio
porzio.giovanni@gmail.com
Ho incominciato a viaggiare, a scrivere e a fotografare quand’ero al liceo e all’università, alla fine degli anni Sessanta. Non sapevo cosa avrei fatto nella vita. Ero spinto da un desiderio irrefrenabile di conoscere le culture più distanti, di penetrare nei luoghi più remoti e inaccessibili, di immedesimarmi negli uomini e nelle donne che incontravo. Annotavo le mie impressioni sui taccuini. Scattavo foto ai cortei del movimento studentesco e durante le vacanze: lunghe scorribande in autostop negli Stati Uniti, in Marocco, in India. Ricordo bene la prima macchina fotografica. Una macchina importante, una Leica che mio padre aveva in casa e che mi regalò, credo nella speranza che la mia curiosità per la fotografia si trasformasse in qualcosa di più serio e consistente. Non avevo ancora vent’anni e scoprivo ogni giorno nuovi territori da esplorare: il cinema, la letteratura, l’arte, la musica, l’amore, la politica. C’erano le occupazioni all’università e gli scontri con la polizia, i concerti rock col sacco a pelo e Jack Kerouac alla libreria Cortina, i piano bar di Brera e i film d’essai all’Obraz Cinestudio, gli esami da dare e i dibattiti su come cambiare il mondo. La Leica non era facile da usare. Non aveva l’esposimetro incorporato. La messa a fuoco era manuale. Le pellicole e la stampa costavano un patrimonio. Prima di scattare dovevi essere sicuro che ne valesse la pena. Lessi alcuni manuali e cominciai a sperimentare, ai giardini pubblici, sui Navigli, per le strade, scomponendo la realtà in inquadrature in bianco e nero, valutando l’incidenza della luce, la composizione, la profondità di campo. Non facevo molti progressi: ero continuamente distratto da mille altri impegni e fantasie. Fu quasi per caso, e più che altro per guadagnare qualche soldo per i miei viaggi, che nel 1971 entrai come vice-vice assistente nello studio di Carlo Orsi, alle colonne di San Lorenzo. A Milano Carlo, vecchio amico di famiglia, era il numero uno dei fotografi di moda. Cover di Vogue, Elle, Vanity Fair, Cosmopolitan. Fantastiche modelle russe, tedesche, americane. Ma Carlo, che si era fatto le ossa con i reportage di cronaca, era soprattutto un grande ritrattista e un mago della camera oscura. Un maestro della luce. Luce naturale: in esterno non l’ho mai visto usare un flash. Passavo ore all’ingranditore, immergevo le dita nei liquidi di sviluppo e di fissaggio, ritoccavo le stampe con lo “sgarzino”, cercando intanto di impadronirmi delle tecniche di ripresa e di esposizione. Ma da Carlo imparai che la tecnica è solo il supporto materiale di una foto, come la penna o il computer per uno scrittore. Altri sono gli elementi decisivi: l’occhio, il cervello, il cuore. Devi chiederti quale significato vuoi dare all’immagine, cosa riesci a leggere in un’istantanea e come puoi sperare di tradurlo in uno scatto. Ci sono foto bellissime che non dicono niente. E altre, tecnicamente imperfette, che ti colpiscono nell’anima: per un’inquadratura insolita, uno sguardo, un taglio di luce obliquo, un’ombra inaspettata, un profilo fuori fuoco... Mi ero nel frattempo persuaso che il giornalismo fosse l’unico mestiere che mi avrebbe permesso di girare il mondo sfruttando la mia propensione alla scrittura.
Dopo la laurea in Scienze Politiche ottenni una borsa di studio del ministero degli Esteri e me andai in Algeria per imparare l’arabo. Tra una traversata in autostop del Sahara e un viaggio in camion nel golfo di Guinea, cominciai a scrivere articoli come freelance su alcuni giornali e riviste di politica internazionale. Rientrato in Italia, fui assunto alla redazione Esteri di Panorama. E la mia vita subì una brusca accelerata. I servizi dai punti caldi del pianeta si succedevano senza sosta: Medio Oriente, Africa, Sudest asiatico, Estremo oriente, America centrale, con qualche rara parentesi sui più tranquilli fronti dell’Europa e degli Stati Uniti. Non mi sono più fermato. I colleghi più anziani ambivano al posto di corrispondente da Parigi o da New York. Io preferivo di gran lunga arrampicarmi con i guerriglieri sulle montagne dell’Eritrea e dell’Afghanistan, raccontare il bombardamento di Beirut, attraversare i campi minati in Mozambico, intervistare i prigionieri iraniani nelle paludi di Bassora. Forse perché ero il più giovane e non ho mai rifiutato un incarico a rischio, ho finito per diventare un “inviato di guerra”. Definizione ambigua, nella quale fatico a riconoscermi. Continuo a considerare il mio lavoro una testimonianza contro la guerra. Anche le guerre che riteniamo necessarie o inevitabili (mai giuste, perché non c’è giustizia nella guerra) sono un ripugnante grumo di morte, miseria e distruzione. Non ci sono eroi e non ci sono vincitori: soltanto vinti. E molto spesso la prima vittima della guerra è l’informazione. I morti non sono uguali. Quando piangiamo i nostri caduti, ci dimentichiamo di quelli che ammazziamo noi. Quando esaltiamo i nostri eserciti, chiudiamo gli occhi sui massacri compiuti per i nostri nobili ideali. Ma i giornalisti hanno il dovere di non distogliere lo sguardo. È un esercizio duro. La guerra riduce tutto all’essenziale: la sottile linea rossa che separa la vita dalla morte. Ti costringe a sprofondare negli abissi del male, a porti interrogativi che non hanno risposte. La guerra è anche una droga. In un suo libro Chris Hedges, inviato del New York Times che in un arroventato febbraio del 1991 mandai al diavolo nel deserto saudita (mi negò l’uso del suo telefono satellitare alla vigilia dell’offensiva americana in Kuwait), analizza con lucidità la forza di attrazione della guerra. “Può darci uno scopo” scrive “un senso, una ragione di vivere. Solo stando in mezzo a un conflitto la meschinità e l’insulsaggine di tanta parte della nostra vita ci appaiono evidenti. La banalità domina le nostre conversazioni e spesso, sempre più spesso, invade anche l’etere. E la guerra diventa un elisir inebriante. Ci rende decisi, ci offre una causa. Ci permette un quarto di nobiltà”. Il migliore antidoto è restare fedeli a se stessi, ancorati ai fatti e al proprio mestiere di cronisti. Rimango sempre di stucco quando leggo sui giornali, italiani e stranieri, le presuntuose analisi degli “esperti” o il commento del trombone di turno che – badando bene a calibrare i toni, con un occhio alla carriera e l’altro all’editore di riferimento – ti spiega che cos’è la guerra che non ha mai visto, tratteggia con mano sicura gli scenari internazionali scopiazzati sui siti dei think tanks e ripartisce un tanto al chilo torti e ragioni, tranciando giudizi inappellabili e dando lezioni di morale. Io mi accontento di raccontare frammenti di vita, spezzoni di realtà. Tenendo a mente la frase che Graham Greene fa dire al protagonista di The Quiet American: “Sono un reporter; Dio esiste soltanto per quelli che scrivono gli articoli di fondo”.
Il termine inglese “reporter” mi è certamente più congeniale: non implica una relazione meccanica con la pubblicazione di un articolo su un giornale, non circoscrive il mezzo alla carta stampata e suggerisce l’atto dinamico del “riportare” da un luogo notizie, ma anche racconti, sensazioni e, appunto, immagini. Ho sempre viaggiato con una macchina fotografica al collo, ma ho ripreso a scattare in modo sistematico e un po’ meno amatoriale negli anni Novanta. Per svariati motivi. Ho sentito il bisogno di corredare i miei servizi con apparati iconografici più puntuali, come le immagini dei personaggi che intervistavo (in quel preciso momento, con quella precisa espressione) e dei luoghi spesso assai remoti in cui mi capitava di trovarmi, non sempre rintracciabili negli archivi elle agenzie. Il respiro e la formula del settimanale, incline all’approfondimento e libero di svincolarsi dalle urgenze della cronaca quotidiana, hanno agevolato i miei passi. L’incontro con Gabriella, compagna di vita e giornalista televisiva, ha poi rafforzato il mio interesse per le immagini. Osservandola dietro la telecamera mi sono reso conto del loro straordinario valore simbolico e impatto mediatico: dove le parole risultavano banali, impotenti, riduttive, inadatte a descrivere uno sguardo o un silenzio angosciato poteva forse arrivare una foto. Una certa foto. Ho anche avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con alcuni grandi fotoreporter come Francesco Zizola e Jim Nachtwey, compagni di viaggio e di avventure, spesso drammatiche, sui fronti di guerra. Da loro ho appreso molto: il modo non invasivo di porsi davanti al soggetto, senza violentarne l’intimità e il dolore, entrando con partecipazione e con rispetto all’interno della foto stessa. Niente teleobiettivi, niente immagini rubate, costruite, strappate di forza. Piuttosto non si scatta, si rinuncia. Si impara ad aspettare.
C’è un altro motivo che mi ha avvicinato ai fotografi e agli operatori televisivi. Loro vanno sempre in prima linea. Il giornalista può scrivere il suo articolo osservando una battaglia da lontano, dal tetto di una casa o da una trincea di retrovia, magari effettuando rapide puntate al fronte. Loro no. Devono essere lì dove l’azione si svolge. Vicini, pericolosamente vicini. Ho visto Jim buttarsi a terra e rotolare illeso per un soffio dietro il muro di una casa a Hebron, sotto il fuoco incrociato delle mitragliatrici. Ed ero a Baghdad quando è stato ferito dall’esposione di una granata lanciata sul veicolo militare dal quale si era sporto per fotografare: il suo collega, inviato di Time, ci ha rimesso la vita. Ero a pochi metri da Marco Di Lauro, nel 2001, durante la battaglia di Kabul, quando un cecchino taliban gli ha sparato alla schiena: lo ha salvato il giubbotto antiproiettile. Molti amici sono caduti sul campo. Mario Ciriello è stato ucciso a Ramallah dalla raffica di un mitra israeliano: stava riprendendo con una mini-telecamera, a distanza ravvicinata, il movimento di un tank. Patrick Bourrat, della tv francese, che era stato prigioniero con me a Bassora nel 1991, è morto schiacciato da un carro armato americano in Kuwait, alla vigilia dell’invasione dell’Iraq. Sarebbe un lungo elenco.
L’avvento di internet, della fotografia digitale, dei sistemi di trasmissione dati via satellite hanno infine concorso a plasmare il profilo di un nuovo genere di giornalista di guerra: il reporter globale, in grado di scrivere articoli, filmare, scattare e trasmettere foto in tempo reale, inviare corrispondenze radiofoniche ed effettuare collegamenti televisivi da ogni angolo del pianeta. È una sfida, vantaggiosissima per i bilanci degli editori, che ho accettato volentieri perché mi consente di esplorare tutte le forme e i linguaggi delle news. Ma è al tempo stesso irta di insidie, perché rischia di alimentare il dilettantismo e la superficialità già dilaganti nel mondo dell’informazione. Scattare delle buone foto, soprattutto in zone di guerra e alle latitudini medio-orientali, richiede un’infinita serie di sforzi e di accorgimenti. Devi alzarti prima dell’alba per sfruttare la luce prima che il sole salga troppo in alto e devi trovarti al posto giusto poco prima del tramonto. Devi sempre mantenere un livello elevatissimo di concentrazione, muoverti con cautela tenendo spalancati occhi e orecchie, fidandoti dell’istinto e della conoscenza del terreno, calcolando le possibili vie di fuga, imparando a riconoscere la differenza tra il frastuono di un proiettile in partenza e quello di una granata in arrivo. Devi gestire la tua paura masticando adrenalina e valutando i rischi, perché non puoi permetterti di sbagliare. Devi essere fulmineo senza perdere la calma e la capacità di osservare. Devi essere lucido e fisicamente in forma, giorno dopo giorno. E di notte, quando un improvviso avvenimento non ti costringe a correre in strada, passi ore al computer a visionare, selezionare, editare, comprimere, trasmettere le immagini. Il giornalista ha esigenze diverse. Deve capire, ascoltare, leggere, approfondire, trovare nuove storie, nuovi personaggi da intervistare. Come il fotografo, va a caccia di notizie, di immagini, di sensazioni e di atmosfere. Ma ha bisogno di tempo per analizzarle, verificarle, coagularle in un breve articolo o distenderle in un racconto. Deve rispettare i tempi di chiusura del giornale, l’impietosa “deadline”, e talvolta le bizzarre richieste di un caporedattore che, lontano anni luce dalla realtà in cui vivi, si è innamorato di un’improbabile notizia sbirciata sul video delle agenzie. Compendiare le diverse esigenze è difficile, spesso impossibile. Ma altre volte il tentativo non è vano. Come forse queste foto stanno a dimostrare. Non vogliono essere un cinico catalogo di sofferenze e crudeltà. Sono state scattate con la convinzione che sia un dovere morale far conoscere ciò che accade nelle guerre e con la speranza che possano scalfire le barriere dell’assuefazione e dell’indifferenza. Perché anche nella più cupa disperazione ho sempre visto balenare un tenue lampo di fiducia nell’uomo: la caparbia certezza che l’orrore non sia inevitabile.
PS. Nel 2010 l’Università degli Studi di Siena, in collaborazione con l’Archivio Fotografico Toscano e con la Società Italiana per lo Studio della Fotografia, hanno concluso il lavoro di digitalizzazione del mio archivio fotografico: oltre 30 mila immagini realizzate in quarant’anni di lavoro.

- 2024, Mexico